Ok, questa è tosta da scrivere. È un libro lungo, ma sticazzi, millecinquecento pagine di avventure della Pimpa scorrono che è un piacere. Qui invece… diciamo che bisogna mettersi di buona lena.
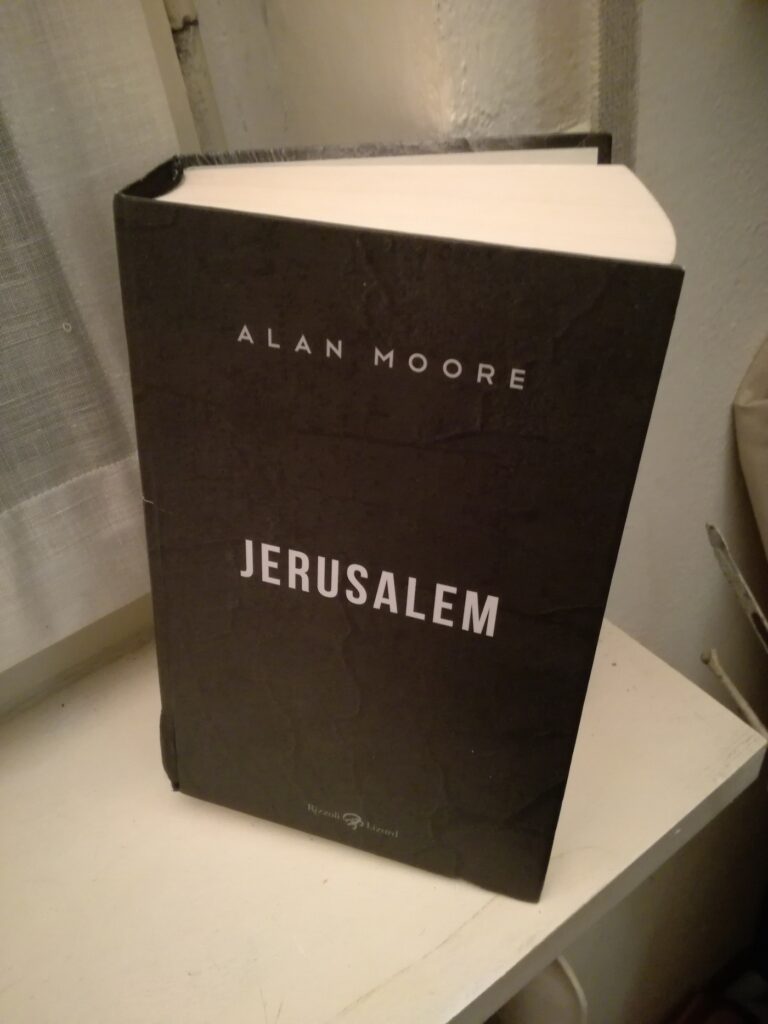
Per semplificare la discussione andrò per punti: trama, temi, giudizio complessivo
TRAMA?
Ahahahhahah. Trama. È un libro postmoderno, frammentario, con una secchiata di personaggi – ho dovuto prendere appunti sul complicato albero genealogico di almeno una ventina di protagonisti. I personaggi fuori dalla famiglia Vernal/Warren non me li sono segnati e mi sa che è stato un errore, perché sul finale era tutto un “ma questo chi è, più?”
Anche i piani temporali sono incasinati. Ho già detto che è un libro postmoderno? Spaziamo dalla preistoria al futuro futurissimo, con morte entropica dell’universo e tutte cose. Ma il grosso dell’azione avviene alla fine dell’Ottocento e poi lungo tutto il corso del Novecento.
L’unica coordinata costante è il luogo. Stiamo e restiamo a Buroughs, un quartiere della città inglese di Northampton, che poi è il protagonista vero dell’opera, con i suoi elementi iconici, le sue trasformazioni, la sua gente sfruttata, violentata, abusata. Il fratello di Rino Gaetano è di Buroughs, per capirci.
Fatemi fare brevemente l’intellettuale. Leggendo Jerusalem il paragone immediato è con Infinite Jest, di David Foster Wallace. Stessa frantumazione, stesso anacronismo, stessa cariolata di personaggi. Qui in realtà uno si orienta un fiiiilo meglio perché appunto il grosso dei protagonisti sono legati da rapporti di parentela, che aiutano a raccapezzarsi (e vabbè, gli anni hanno ancora i numeri, non i nomi degli sponsor).
Come Infinite Jest, la trama si può apprezzare in due modi: A) con una guida piena di annotazioni in modo da non perdersi, tipo questa, oppure B) lasciandosi trasportare dal flusso, e accogliendo ogni scena come una singola scintilla. Quale approccio ho scelto ho scelto secondo voi?

Mi sono perso dei dettagli strada facendo? Certo. Ma un uomo deve anche sopravvivere. Avevo fatto la stessa cosa con Infinite Jest e rivendico con orgoglio il mio approccio da guerriglia letteraria.
(Cmq la sintesi della trama è: “Grande affresco di una città che cambia. E fantasmi.”)
TEMI?
Il tempo, il tempo, il tempo e la pazzia. Ma soprattutto il tempo.
Moore spiega e sviluppa la corrente filosofica dell’eternalismo, che dice che tutto il tempo esiste sempre, ma che la nostra percezione umana lo digerisce un secondo alla volta. Non è una cosa che si è inventato lui, eh, anche Einstein era un noto eternalista. L’idea è che tempo e spazio sono legati (il famoso continuum spaziotemporale). E l’idea è anche che se io vado a Tokyo, poi a Roma, non è che Tokyo smette di esistere. Sono io che percepisco un luogo alla volta. Epperò se spazio e tempo sono legati, yadda yadda, eternalismo.
(eternalismo in opposizione al presentismo, che dice che esiste solo il presente)
Dunque, qui non vorrei fare troppi spoiler, ma per motivi che scriverò più sotto: tutto sommato sticazzi. Puoi saltare questo paragrafo se proprio non sopporti l’idea di ricevere delle minuscole anticipazioni, ma guarda che secondo me non cambia molto. Dunque, dicevo, Moore sviluppa l’eternalismo alla sua maniera, ovvero disvelando la natura della morte. Si muore, e fin qui non ci sono grosse sorprese. La sorpresa è che la nostra coscienza permane, e volendo l’esperienza che abbiamo avuto della vita può ancora essere vissuta. E ancora, e ancora, infinite volte, sempre uguale, sempre fresca perché tanto non si mantiene il ricordo dei cicli precedenti (anche se una delle sottotrame segue un gruppo di personaggi che cercano un’eccezione proprio a questa regola, ma son dettagli). Oppure, post mortem, si può vivere una nuova vita come fantasmi, tra inferno (se sei morto pieno di rancori e infelicità) e purgatorio (il secondo Buroughs, la versione celeste e multidimensionale del quartiere di Moore). E il paradiso? Puppa. C’è e non c’è, nessuno vi accede e però è nota la sua presenza. Mistero della fede.
Altro tema: la pazzia, intesa proprio come malattia mentale, presente in senso molto concreto dato che un tot di protagonisti – specialmente femmine – ogni tanto “voltano l’angolo”. Cioè smattano. Che poi uno va a vedere e c’è sempre un motivo valido, una congiuntura che ti fa dire che anche tu, in una situazione simile, non avresti mantenuto il distacco. Anche tu avresti smattato, almeno un pochetto. E forse è questo il messaggio di fondo? Che la malattia mentale è causata da quanto riusciamo ad essere stronzi gli uni con gli altri? (cioè: tanto). Nota che quando Moore parla di “malattia mentale” si riferisce a una dimensione un po’ vintage, più stile “questa donna è intrattabile, è un chiaro caso di isterismo”, e meno stile “sono uscito a comprare il pane e mi è venuto un attacco di panico”. Diciamo che il suo punto di riferimento sono i primi del Novecento. Ma tanto che gli frega, tutto il tempo è eterno.
Altro tema: Alan Moore. Eh sì, non si scappa, questo è un libro che parla proprio di lui.

Alma Warren, uno dei protagonisti, è il suo doppione in versione femminile, e neanche tanto velatamente (peraltro, trivia: l’ho immaginata per tutto il tempo con la faccia della tizia di Russian Doll). E la famiglia Vernal/Warren è la famiglia Moore, con tanto di ringraziamenti finali alle persone citate, aneddoti che si capisce in controluce che sono successi davvero, e una grande operazione nostalgia. Perché sì, perché l’amarcord è sempre di moda, perché anche quando ci parla di fantasmi quadridimensionali e mostri fluviali il messaggio di Moore è sempre quello: come sono vecchio/come si stava bene una volta/il mondo sta andando a rotoli/grandi sospiri.

Altro tema: il capitalismo fa schifo. Vabbè su questo è dura fare delle critiche. Conta che Moore si è fatto tuuuutto il governo Tatcher, sono cose che ti segnano.
Cameo apprezzatissimo: compaiono di striscio i KLF, i tizi adoratori del caos che hanno bruciato un milione di sterline, di cui avevo già parlato.
SÌ MA È UN BEL LIBRO?
Sì.
Sì, è un bel libro, però dobbiamo capirci. È un libro bello, interessante, che ti fa pensare, con alcune pagine scritte in maniera struggente, che segue un formalismo rigidissimo, trentatrè capitoli divisi su tre volumi da undici, grande simmetria, la circolarità dei temi ripresa nella circolarità della struttura narrativa. Ma non è un libro appassionante, mai. Che è uno dei limiti del postmoderno, a ben guardare e secondo me. Anche di Infinite Jest, di cui sopra, penso la stessa cosa: caratura simile, limiti simili. Quando mi presenti una storia corale, piena di frammenti, di salti temporali, senza trama, con un punto di vista che si accosta brevemente ad un personaggio per poi allontanarsi e non tornarci mai più, ecco, quando fai tutto questo poi è difficile suscitare una reazione di pancia.
Di testa, sì. Certo. È un libro interessante. Ma di pancia no, mai. Non è appassionante. Epperò sono arrivato in fondo, un po’ per orgoglio, un po’ perché le parti belle superano di gran lunga quelle noiose (seppur presenti).
È un libro che andrebbe riletto. So che se lo rileggessi ora coglierei molte cose che mi sono perso per strada. Ma non lo farò, è un libro bello ma non così bello. Magari lo riprenderò in mano tra qualche anno, e per allora mi sarò dimenticato tutto o quasi, e tornare su quelle pagine sarà un’esperienza nuova. Proprio come i fantasmi del romanzo, condannati a ripetere per sempre le proprie vite. Tutto torna.

